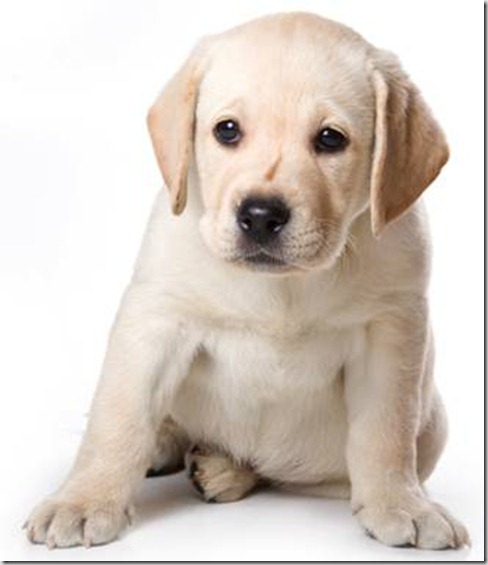In questo articolo parleremo di un’altra diffusa cardiopatia congenita nel cane, il dotto arterioso persistente detto anche dotto arterioso pervio o di Botallo.
Il dotto arterioso di Botallo rappresenta la connessione fra l’arteria polmonare e l’aorta, attraverso la quale gran parte del sangue venoso che giunge all’arteria polmonare passa nell’aorta discendente. Nei primi due tre giorni di vita il dotto arterioso pervio si chiude. Quando il dotto rimane pervio, si verifica uno shunt da sinistra a destra che causa un sovraccarico di volume polmonare e cardiaco sinistro.
Il PDA è la più comune cardiopatia congenita nel cane ed è prevalentemente osservato nel Barbone , nel Collie, nel Pomerania, nel Pastore dello Shetland, nel Cocker Spaniels, nello Yorkshire Terrier, nel Maltese, nel Setter Irlandese e nel Pastore Tedesco.
Le femmine sembrano essere più predisposte dei maschi. Il PDA è stato segnalato anche nei gatti.
Nelle forme più comuni lo shunt avviene tra l’aorta e l’arteria polmonare. La quota di sangue che passa attraverso il dotto è proporzionale alle dimensioni dello stesso e alle resistenze polmonari. Il passaggio di sangue dall’aorta all’arteria polmonare determina un iperafflusso al circolo arterioso polmonare, che induce a sua volta un sovraccarico diastolico dell’atrio e del ventricolo sinistro. Questo determina l’ingrandimento di queste due camere cardiache e l’ipertensione polmonare.
Caratteristiche cliniche
La gravità dei soggetti affetti da PDA varia in funzione della quota di sangue che passa attraverso lo shunt.
I reperti classici dell’esame obiettivo nel PDA sono i polsi arteriosi ipercinetici, il soffio cosiddetto “ a rumore di locomotiva “ continuo a livello dell’ascella e la colorazione rosea delle mucose.
Il polso femorale si definisce ampio, saltellante o rimbalzante, per la rapida riduzione della pressione diastolica dovuta al flusso di sangue attraverso il PDA e per l’aumento della pressione sistolica legata all’aumentato ritorno venoso al cuore sinistro.
Le alterazioni radiografiche riflettono il sovraccarico volumetrico. In quasi tutti i casi di PDA nei radiogrammi del torace sono evidenti segni di congestione venosa polmonare, caratterizzati da un’aumentata radiopacità degli spazi peribroncovascolari, da una dilatazione dell’arco aortico e dell’arteria polmonare principale particolarmente evidente nelle proiezioni dorso-ventrali. All’esame della silhouette cardiaca si apprezza un ingrandimento dell’atrio e del ventricolo sinistro particolarmente evidente nelle proiezioni latero.laterali.
L’alterazione più frequente dell’elettrocardiogramma é la presenza di onde R grandi nella seconda derivazione a causa di un ingrandimento ventricolare sinistro. Nelle forme più gravi e in quelle avanzate si possono riscontrare aritmie importanti, quali extrasistoli ventricolari, sopraventricolari e fibrillazione atriale.
L’esame ecocardiografico consente di apprezzare tutte quelle modificazioni strutturali e dinamiche del cuore e dei grossi vasi conseguenti alla persistente pervietà del dotto arterioso.
La presenza di un flusso retrogrado continuo e turbolento a livello dell’arteria polmonare principale è caratteristico del PDA. Il dotto è visibile nella proiezione parasternale destra trasversale e nella parasternale sinistra craniale, come uno spazio ipoecogeno situato tra l’ arteria polmonare principale e l’aorta. Abitualmente la migliore immagine si ottiene nella proiezione parasternale sinistra craniale.
Terapia
I pazienti con PDA, se non si corregge il difetto, sviluppano insufficienza cardiaca congestizia e presentano un tasso di mortalità superiore al 60% durante il primo anno di vita. In qualche occasione i segni clinici non si rendono evidenti fino alla maturità ma nella maggior parte dei casi si manifestano entro il terzo anno di vita. Circa la metà dei cani con PDA e con un’età superiore all’anno, presentano tosse, collasso, intolleranza all’esercizio, letargia e dispnea.
Il trattamento chirurgico è l’unico mezzo effettivo di trattare un PDA con shunt sinistro-destro. Negli ultimi anni il cateterismo cardiaco e l’approccio percutaneo delle tecniche mini-invasive, hanno soppiantato la chirurgia tradizionale per il trattamento della maggior parte dei pazienti con PDA.
L’occlusione transcatetere del PDA fornisce un’alternativa minimamente invasiva alla legatura chirurgica a cielo aperto, evitando la necessità di effettuare la toracotomia con la relativa morbilità chirurgica.
Articolo a cura della Dott.ssa Daniela Ferrari, Clinica Veterinaria Borgarello
Se ti è piaciuto l'articolo, iscriviti al feed o alla newsletter per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti di TGVET.net.
Lascia un commento per dire la tua o per chiedere informazioni