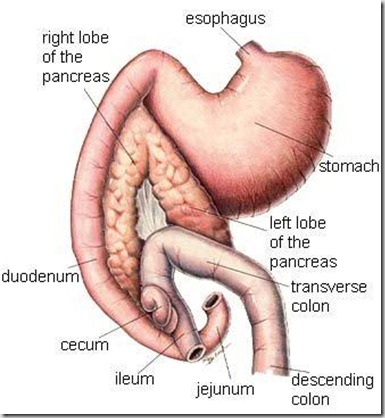Il termine entropion indica il ripiegamento completo o parziale della palpebra verso la superficie oculare, il quale determina una rotazione delle ciglia che irritano e traumatizzano la congiuntiva e la superficie corneale. A seconda della gravità del difetto si riscontrano epifora (aumento della fuoriuscita di lacrime), blefarospasmo (spasmo del muscolo orbicolare dell'occhio), congiuntivite, cheratite o erosioni epiteliali. 
L'entropion può essere un difetto primario (di sviluppo) o secondario (acquisito) e in molte razze canine è considerata una patologia ereditaria.
La forma ereditaria è osservata spesso nel Chow Chow, San Bernardo, Sharpei, Mastino napoletano, Bulldog, Setter inglese, Cocker americano ed inglese, Labrador e Golden Retriever.
L'entropion primario si può manifestare tra i 3 e i 10 mesi di vita, ma in alcune razze come il Rottweiler può presentarsi un po' dopo, verso l'anno d'età: questo è dovuto al fatto che la crescita pronunciata della cute e del tessuto sottocutaneo della testa rispetto alla base scheletrica e al globo oculare, conduce ad una perdita di supporto delle palpebre che spesso vanno incontro ad anomalie. 
Si presenta solitamente in entrambi gli occhi e può essere associato a vari fattori, quali dimensione dell'orbita, lunghezza palpebrale e tono del muscolo orbicolare.
L'entropion acquisito è in genere di origine cicatriziale o secondario a perdita di tono del muscolo orbicolare o dei muscoli extraoculari, con conseguente enoftalmo (per riassorbimento del tessuto adiposo retrobulbare). Inoltre può essere indotto da spasmo (blefarospasmo di tipo spastico).
Occorre tenere in considerazione questi elementi durante la visita oculistica e l'applicazione di anestetico locale può ulteriormente aiutare nel giudicare il grado di entropion , prima di deciderne la correzione chirurgica. 
Molte sono le tecniche chirurgiche descritte per la correzione dell'entropion, ma la più utilizzata è quella di Hotz-Celsus modificata, nella quale vengono rimossi, nella zona adiacente al difetto, un lembo di cute e di muscolo orbicolare che successivamente vengono suturati con filo non riassorbile a punti staccati partendo dalla zona centrale.
Considerata l'elevata incidenza del difetto in alcune razze canine, si ricorda ai proprietari di non sottovalutare quelli che possono essere i sintomi premonitori di un probabile entropion: infatti, come accade in molte altre malattie, la diagnosi precoce evita la cronicizzazione della malattia con la conseguente comparsa di danni irreversibili.
A cura della Dott.ssa Valentina Declame
Se ti è piaciuto l'articolo, iscriviti al feed o alla newsletter per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti di TGVET.net.
Lascia un commento per dire la tua o per chiedere informazioni










![clip_image002[6] clip_image002[6]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3uFvM68LEe5vmgZGbRtBnizL9xxD1HWqnjU44DAQxedBCqvcRS4sPjnn3PQBiy569XyOt8EcvxylkLY-aL1ilDLaB0MGNGC6a6qCt-aOj_-ssbPEOCbtRaPzf7THf5T2fjaIGS0deiv_R/?imgmax=800)